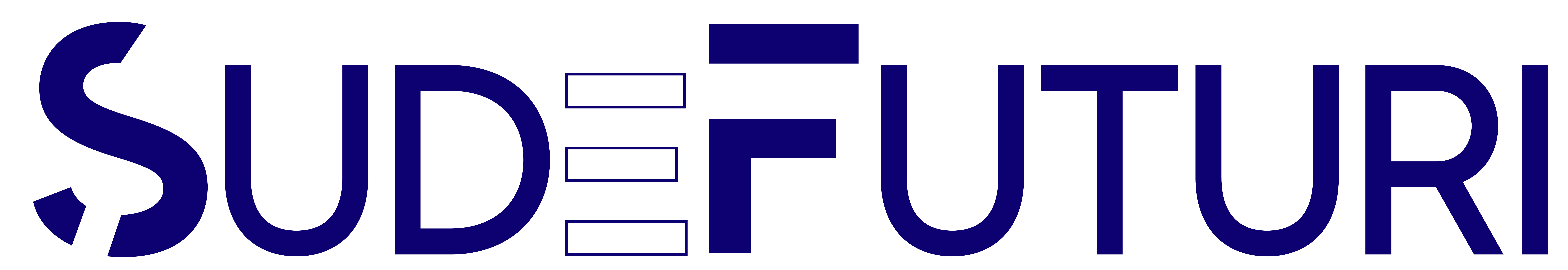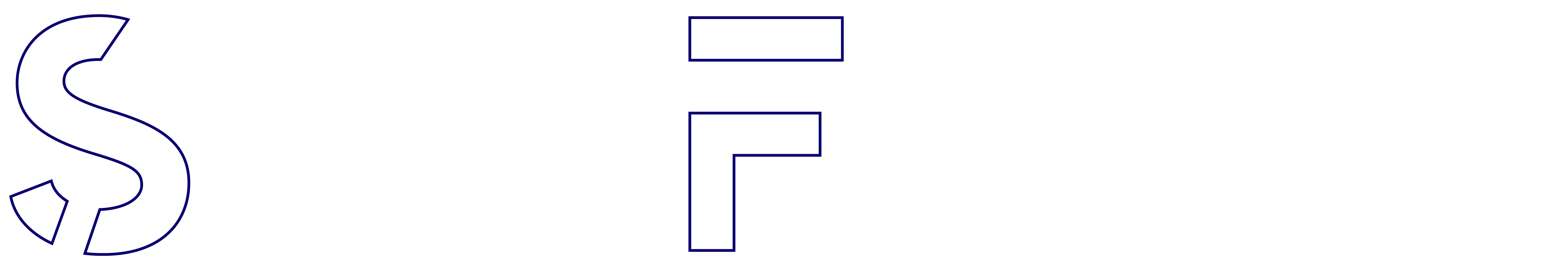L’incredibile storia inizia nel 1956 da un villaggio algerino raso al suolo dai francesi e i cui abitanti, compresi donne e bambini, furono massacrati
Ci sono fotografie che sono entrate nella storia, accreditandosi per il loro soggetto, spesso sconosciuti che, per quello scatto rubato, hanno potuto ritagliarsi, talvolta loro malgrado, un posto nella memoria collettiva.
Come Kim Phúc Phan Thi, la bambina (aveva nove anni) sudvietnamita che nel 1972 fu fotografata mentre correva, nuda dopo che una bomba al napalm le aveva bruciato le vesti e, con esse, le carni.
Come Nguyễn Ngọc Loan, capo della polizia nazionale del Sud Vietnam, immortalato mentre, il primo febbraio del 1968, stava sparando alla testa di un altro ufficiale, ma vietcong, Nguyễn Văn Lém, accusato di avere poco prima massacrato, sgozzandoli, un militare di Saigon e la sua famiglia, bambini compresi.
Come Greta Zimmer Friedmann, l’infermiera, e George Mendonsa, il marinaio, protagonisti di quello che è passato alla storia come ”il bacio di Times Square” (questo vero, reale, non come quello ben più famoso costruito da Robert Doisneau, davanti al municipio di Parigi, nel 1950) , il 14 agosto del 1945, nelle ore successive all’annuncio che la guerra era finita. Un bacio tra due sconosciuti, cristallizzato dal Alfred Eisenstaedt, paradossalmente d’origine tedesca.
tante storie con interrogativi in attesa di risposta
Ma ci sono storie che dalle fotografie trovano uno spunto per interrogativi che sono ancora lì, in attesa di avere le risposte, tutte le risposte.
Spesso si tratta di scatti poco conosciuti, quasi sempre non professionali e che non trasmettono alcun messaggio emozionale. Foto di ambientazione neutra, senza drammi o momenti di particolare emozionalità, ma che spingono a formulare delle domande su chi vi è ritratto.
La storia che cercherò di raccontare nasce da alcune fotografie ”normali”, che, in un album di famiglia, conservato oggi in un cassettone di una casa francese, ritraggono un bambino dallo sguardo sveglio, dalla pelle chiara e dal sorriso bellissimo. Un sorriso come di chi non conosce – o non dovrebbe conoscere – le brutture del mondo, di chi sta vivendo il suo essere bambino secondo i canoni della normalità: una famiglia, gli appuntamenti canonici con tanto di regali, i giochi, il divertirsi. Fotografie che nel tempo sono apparse su qualche giornale, ma non traducono completamente la drammaticità delle vicende che stanno dietro ad esse.
Vicende di una cultura imposta, di una assimilazione forzata, di una religione che ha sostituito quella della sua gente. Vicende di un bambino che è cresciuto con gli assassini dei suoi genitori (no, forse non assassini, ma con quelli che, in un ”atto di guerra”, li hanno uccisi). Un bambino che ha scoperto una verità che, pur non rispondendo a tutte le sue domande, lo ha fatto inorridire, perché ha capito d’essere stato una pedina, di avere seguito un percorso di vita disegnato da chi aveva le mani ancora sporche del sangue di chi la vita gliela aveva data.
Fotografie, di qualità quasi scadente, in un bianco e nero dai contorni poco definiti e con il soggetto principale, il bambino, quasi sempre attorniato da adulti che lo guardano con simpatia, forse anche affetto, ma che non sono quelli che la sua storia personale gli avrebbe dovuto riservare.
un bambino con la veste bianca e la tutà mimetica da parà
Un bambino ritratto con addosso la veste bianca di chi s’accosta ad uno dei sacramenti che segnano l’inizio della vita del buon cattolico, ma anche con la tuta mimetica di un parà. Quel bambino si chiama Maxime-Charles Keller de Schleitheim ed ora ha quasi 69 anni.
Una storia (che non è la sua, ma che gli è stata imposta) che appare ancora oggi incredibile perché è difficile pensare a quanto gli è accaduto e non inorridire.
Il primo capitolo di questa vicenda può essere fissato al 18 maggio del 1956, quando l’Algeria era dilaniata dalla guerra di indipendenza che i due schieramenti combattevano come sapevano, con le loro armi: sangue, violenza, orrore, massacri.
Ammal era, in quegli anni, più che una comunità un insieme di piccoli insediamenti. Nel suo territorio se ne contavano parecchi: Ouled Djerrah, Béni Hini, Béni Dahmane, Ouled Bellemou, Tigueur Ouacif, Tigrine, Aït Ouelmène, Ticjedjiga e Aït Amar.
Spesso, fidando sulla complicità degli abitanti, tutti schierati con gli indipendentisti, i soldati dell’Esercito di liberazione nazionale li utilizzavano come basi per le operazioni nelle zone di montagna del Piccolo Atlante (tra Blida, Médéa e Bouira, rispettivamente a nord, sud ed est).
Il 18 maggio una unità francese, forte di una ventina di uomini (si trattava della seconda sezione del nono reggimento di fanteria coloniale, di base nella città di Palestro, che poi, dopo l’indipendenza, sarà ribattezzata Lakhdaria) , cadde ad Ouled Djerrah, in una sanguinosa imboscata tesa dal commando Ali Khodja.
Non avendo più notizie dell’unità, il giorno seguente lo stato maggiore francese inviò nella zona alcuni reparti, tra i quali i paracadutisti della base 146 di Réghaïa, il primo reggimento di paracadutisti composto interamente dai (temutissimi, per la loro ferocia) militari della Legione straniera e il 20/mo battaglione di fanteria. Nella zona furono fatti arrivare anche quattro elicotteri Sikorski per collaborare alle ricerche. Per cinque giorni la zona fu battuta palmo a palmo, sino a quando fu individuato il luogo dell’imboscata, dove giacevano i cadaveri mutilati di 18 dei 20 componenti l’unità attaccata (gli altri due probabilmente erano stati rapiti e non sono mai stati trovati).
la durissima vendetta dei francesi
La risposta francese fu durissima. Una ”vendetta” che si tradusse nell’attacco ai piccoli insediamenti, i douars, con il massacro di molti dei loro abitanti.
Uno dei piccoli insediamenti investiti dalla vendetta francese fu il douar di Ouled Djerrah, contro il quale i parà si accanirono. Il villaggio fu letteralmente raso al suolo e i suoi abitanti – compresi donne e bambini – massacrati. Dopo l’attacco, un gruppo di soldati, mentre stava attraversando le viuzze del douar per completare l’operazione di ”pulizia”, vide che tra i cadaveri accatastati c’era anche un bambino in lacrime, di quattro-cinque anni, abbracciato al corpo di un uomo, forse il padre, crivellato di proiettili. Vedendo che i soldati si stavano avvicinando al figlioletto, la madre, sebbene ferita, lanciò al cielo dei ”youyous”, le particolari grida delle donne arabe, quasi a cercare di salvare il bambino, ma fu falciata da una scarica di mitra.
il destino di un bambino segnato dalla scelta di un parà
Il destino del bambino sembrava segnato quando un militare lo prese di mira con il suo mitra, ma fu fermato da un altro parà. Il bilancio della rappresaglia scatenata per vendicare l’imboscata fu pesante per i civili, ma anche per i guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale che avevano cercato di nascondersi nelle grotte vicine al villaggio, dove furono stanati e uccisi da gas asfissianti. Si contarono oltre 200 morti, con un solo sopravvissuto al massacro: il bambino di Ouled Djerrah.
Una volta completata la ”bonifica” del territorio, i soldati francesi fecero rientro nelle loro caserme, e nella base dell’aviazione 146 di Réghaïa fu portato il bambino di Ouled Djerrah, cui – dopo essere stato visitato dall’ufficiale medico più alto in grado, il capitano Roger Joseph – fu dato un nome, Maxime. Francese, ovviamente. Il primo passo di un lungo e doloroso cammino di trasformazione cui fu sottoposto, suo malgrado.
il piccolo adottato in caserma

Ma, dal suo ingresso nella caserma, il bambino non fu solo un piccolo profugo perché, cancellandone le radici, i francesi lo adottarono, facendolo vivere attivamente nella base, persino portandolo con loro nelle operazioni (spesso erano rastrellamenti) ed anche utilizzandolo per azioni di intelligence, chiedendogli cioè di spiare i movimenti delle unità dei combattenti indipendentisti.
Il coinvolgimento di Maxime fu tale che il comandante dell’aviazione francese in Algeria, il generale Alain Dumesnil de Maricourt, chiese espressamente al tenente colonnello Coulet, della base di Réghaïa, di fare confezionare per Maxime di una vera e propria tenuta da paracadutista, con tanto di tuta mimetica, berretto, cinturone e, persino, pistola.
Per capire quello che il bambino era diventato si deve citare un altro episodio. All’inizio del 1957 fu ufficialmente costituito il gruppo dei commandos paracadutisti (composto da 102 uomini) denominato con la sigla 40/541. Ma il loro nome in codice fu «Maxime», come venivano chiamati nelle loro comunicazioni radio.
Nel 1959, il piccolo Maxime viveva ancora nella base di Réghaïa, tanto che la sua presenza fu notata da alcuni giornalisti di Paris Match che stavano facendo dei reportage sulla guerra e che avrebbero voluto scrivere – ma non fu loro permesso – di quel bambino che giocava tra elicotteri, camion e mezzi blindati come se fossero elementi di una giostra.
Il 25 ottobre del 1959 il bambino fu battezzato con il nome di Maxime-Charles. Il cognome, Keller de Schleitheim, era quello dell’assistente sociale della base di Réghaïa, Yvonne, che ne perfezionò l’adozione il 28 dicembre successivo.
una vita non rosea per Maxime
Ma la vita di Maxime non fu quella di un bambino coccolato, circondato da mille attenzioni perché per più di sei anni dentro la base svolgeva compiti che certo non si adattavano ala sua età: lavorava in cucina, faceva le pulizie, spazzava.
Il 5 luglio del 1962 fu il giorno della proclamazione dell’indipendenza dell’Algeria e della fine ufficiale delle ostilità. Le truppe francesi cominciarono a tornare in patria, anche quelle di stanza nella base aerea 146 di Réghaïa. Quindi pure Yvonne Keller, che portò con sè il figlio adottivo.
Con il passare degli anni il bambino, diventato ragazzo e quindi uomo, si pose sempre le stesse domande per capire chi lui fosse veramente, dal momento che la sola cosa che gli fu rivelata era che i genitori erano morti durante la guerra d’Algeria – senza dire su quale schieramento si fossero trovati – e che doveva ai francesi d’essere stato salvato da morte. E per lui, gli fu detto, era stata una fortuna perché aveva ottenuto la cittadinanza francese, ”guadagnandosi” così anche la conversione al cattolicesimo. Ma quel che per lui era devastante fu di non sapere quali fossero le sue radici e, come disse poi, d’essere stato assimilato agli harkis, come venivano chiamati gli ausiliari algerini che, sotto le bandiere francesi, combattevano i loro fratelli e lo facevano con disumana determinazione. A completare la ”francesizzazione” del sopravvissuto al massacro di Ouled Djerrah, su un registro di Stato civile francese lui fu iscritto come Maxime-Charles Keller de Schleitheim nato il 18 dicembre del 1951 ad Algeri.
tante domande senza risposta
Con il passare degli anni, i rapporti tra Maxime-Charles e la madre adottiva divennero difficili, dal momento che lui continuava a fare domande che non avevano risposta. Diventato uomo, nel 1972 si sposò, ebbe due figli e ora vive nella regione di Bordeaux, con i familiari. Ma non ha ancora rinunciato a cercare la verità, non quella che per anni gli è stata spacciata. Una battaglia che è andata avanti per 40 anni per vedersi restituito il suo passato, a cominciare dalle ferite morali rimediate nell’attacco a Ouled Djarrà e che tutti hanno voluto negargli. Per questo ha chiesto, sinora invano, che qualcuno dei soldati e degli ufficiali che parteciparono al massacro parli, ma fino ad oggi nessuno ha raccolto il suo appello. Ad aggiungere ombre al mistero la scelta inspiegabile della madre adottiva di distruggere tutte le fotografie in suo possesso che raccontavano la vita di Maxime dentro la base. Qualcuna di quelle fotografie però si è salvata.
Maxime, stanco, ha abbandonato la sua battaglia. Ma a raccogliere il testimone è stata la figlia Karine che, sulla vicenda del padre, ha scritto un libro, ”Il bambino soldato di Palestro” che è anche diventato una piece teatrale.