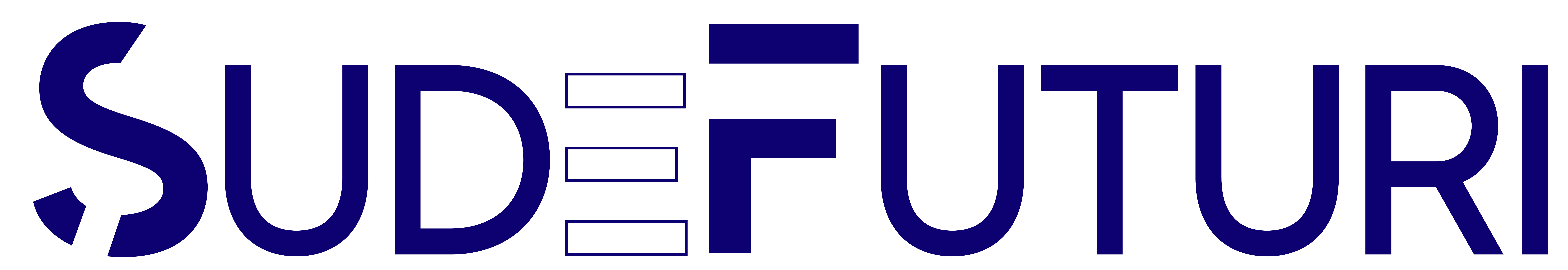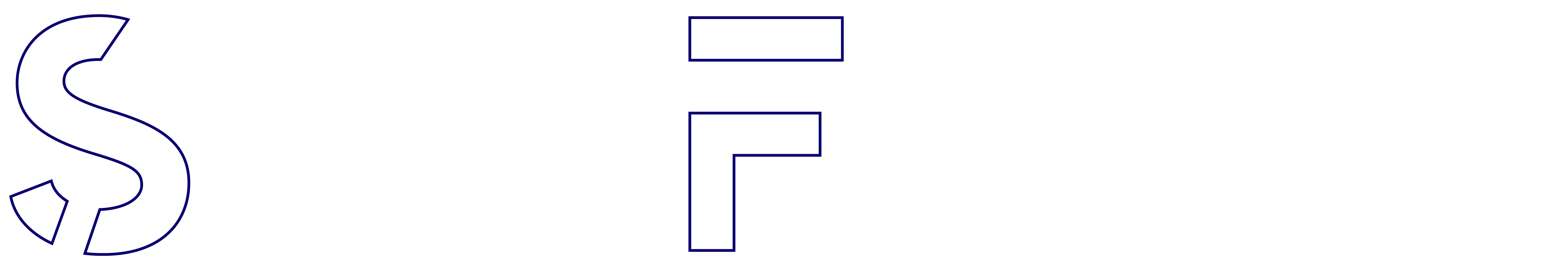Prosegue il declino demografico: impietoso il quadro Istat per il 2024 con la fecondità al minimo storico. Allo stesso tempo cresce la speranza di vita e supera i livelli pre Covid. Il Trentino la regione con la fecondità più elevata, tra le provincie si distinguorno Bolzano, Crotone e Reggio Calabria, Agrigento e Catania
Il 2024 si conferma un anno di svolta per la demografia italiana secondo l’ultima ricerca Istat, con la fecondità e le nascite ai minimimi. I segnali di allarme sono molteplici: una natalità ai minimi, una popolazione sempre più anziana, un tessuto familiare che cambia e una mobilità che accentua le disuguaglianze territoriali. Boom di emigrazioni italiane: raggiunta quota 191mila (+20,5%) soprattutto verso Germania, Spagna e Regno Unito. Segnale positivo sul fronte della salute: la speranza di vita torna a crescere, raggiungendo gli 83,4 anni, con un guadagno di 5 mesi rispetto al 2023 (qui i dati completi).
Fecondità e nascite: il quadro Istat
Il quadro demografico italiano tracciato dall’Istat nel report Indicatori demografici 2024 conferma un’Italia in profonda trasformazione: meno nascite, più emigrazioni, invecchiamento marcato della popolazione e strutture familiari sempre più ristrette. Un lento ma costante declino che incide sul tessuto sociale ed economico del Paese.
Fecondità e nascite, trend mai così basso: solo 1,18 figli per donna
Nel 2024 la fecondità ha toccato il minimo storico: 1,18 figli per donna, superando al ribasso il precedente record negativo del 1995 (1,19). I nuovi nati sono stati solo 370mila, 10mila in meno rispetto al 2023 e ben 156mila in meno rispetto al 1995. A pesare è anche l’età media delle madri, salita a 32,6 anni, segno di una maternità sempre più posticipata.
Nascite, in Trentino-Alto Adige la fecondità più elevata
Il primato della fecondità più elevata continua a essere detenuto dal Trentino-Alto Adige, con un numero medio di figli per donna pari a 1,39 nel 2024, comunque in diminuzione rispetto al 2023 (1,43). Come lo scorso anno seguono Sicilia e Campania. Per la prima, il numero medio di figli per donna scende a 1,27 (contro 1,32 del 2023), mentre in Campania la fecondità passa da 1,29 a 1,26. In queste regioni le madri sono mediamente più giovani: l’età media al parto è pari a 31,7 anni in Sicilia e a 32,3 in Trentino-Alto Adige e Campania (Figura 4).
Fecondità e nascite, Sardegna fanalino di coda
La Sardegna si conferma la regione con la fecondità più bassa: nel 2024, il numero medio di figli per donna è pari a 0,91, stabile rispetto al 2023. Tra le regioni con i valori più bassi di fecondità figurano il Molise (1,04), la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (che sperimenta la flessione maggiore, da 1,17 a 1,05) e la Basilicata (1,09, stabile sul 2023). Basilicata, Sardegna e Molise sono anche le regioni con il calendario riproduttivo più posticipato, dopo il Lazio (33,3 anni): nelle prime due l’età media al parto è pari a 33,2 anni, per il Molise è uguale a 33,1.
Fecondità e nascite, nel Mezzogiorno l’eccezione Calabria
Nel quadro di una fecondità bassa e tardiva, diffusa in tutto il Paese, con differenze tra le ripartizioni geografiche sempre più lievi, si evidenziano ancora condizioni di eterogeneità. Solo le regioni del Mezzogiorno, con l’eccezione della Calabria, raggiungono il proprio minimo storico nel 2024. Nelle regioni del Centro-Nord, livelli più bassi di fecondità di quelli attuali si erano già registrati tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta. In particolare, in Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana si erano già avuti in tali anni livelli di fecondità inferiori all’unità.Differenze tra territori persistono poi anche all’interno di una stessa ripartizione geografica. Nel Mezzogiorno, ad esempio, coesistono regioni che registrano la più alta fecondità nel contesto nazionale (Sicilia, Campania e Calabria) e regioni caratterizzate da livelli minimi (Sardegna, Molise e Basilicata).
Bolzano, Crotone e Reggio Calabria le province con il più alto numero di figli
Tra le province, quella in cui si registra il più alto numero medio di figli per donna è la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (1,51 contro 1,57 del 2023). Seguono le province calabresi di Crotone (1,36) e Reggio Calabria (1,34) e quelle siciliane di Ragusa, Agrigento (entrambe 1,34) e Catania (1,33). Le province sarde sono quelle in cui si osserva la fecondità più bassa, per tutte inferiore all’unità, da Cagliari, che registra un valore pari a 0,84 fino a Nuoro, con un tasso dello 0,98. A queste seguono le province di Viterbo (1,00) e Prato (1,01), nel Centro, e due province collocate rispettivamente nel Mezzogiorno e nel Nord: Isernia e Biella, entrambe con una fecondità pari a 1,04.
Fecondità e nascite: popolazione in calo, ma con divari territoriali
La popolazione residente al 31 dicembre 2024 è di 58 milioni e 934mila unità, in calo di 37mila (-0,6 per mille). Tuttavia, il decremento non è omogeneo: mentre il Nord cresce (+1,6 per mille), il Mezzogiorno continua a perdere abitanti (-3,8 per mille), con punte critiche in Basilicata (-6,3) e Sardegna (-5,8).
Nel 2024 cresce la speranza di vita: + 5 mesi rispetto al 2023
Rilevante crescita della speranza di vita in Italia che nel 2024 è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023. E’ quanto emerge dagli indicatori demografici dell’Istat diffusi oggi. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente conta 58 milioni 934mila individui (dati provvisori), in calo di 37mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente.
non si ferma la diminuzione della popolazione al sud
La diminuzione della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014 e il decremento registrato nel 2024 (-0,6 per mille) è in linea con quanto osservato negli anni precedenti (-0,4 per mille del 2023 e -0,6 per mille nel 2022). Il calo di popolazione non coinvolge in modo generalizzato tutte le aree del Paese. Mentre nel Nord la popolazione aumenta dell’1,6 per mille, il Centro e il Mezzogiorno registrano variazioni negative rispettivamente pari a -0,6 per mille e a -3,8 per mille.
Nord attrattivo, Sud in fuga
Il saldo migratorio interno penalizza il Mezzogiorno (-52mila), mentre il Nord guadagna 47mila residenti grazie ai trasferimenti da altre aree del Paese. Nelle aree interne del Paese si osserva una perdita di popolazione più intensa rispetto ai centri. A livello regionale, la popolazione risulta in aumento soprattutto in Trentino-Alto Adige (+3,1 per mille), in Emilia-Romagna (+3,1 per mille) e in Lombardia (+2,3 per mille). Le regioni in cui si riscontrano le maggiori perdite sono invece la Basilicata (-6,3 per mille) e la Sardegna (-5,8 per mille).
Boom di emigrazioni italiane ma anche di domande di cittadinanza
Le emigrazioni verso l’estero hanno raggiunto quota 191mila (+20,5%), spinte dall’esodo di cittadini italiani (156mila, +36,5%). I Paesi preferiti sono Germania, Spagna e Regno Unito. Al tempo stesso, sono aumentate le acquisizioni di cittadinanza italiana: 217mila nel 2024, nuovo record assoluto. In testa gli albanesi (31mila), seguiti da marocchini e rumeni.
Fecondità e nascite: famiglie sempre più piccole e sole
Il numero medio di componenti per famiglia è sceso a 2,2, rispetto ai 2,6 di venti anni fa. Oggi oltre un terzo delle famiglie italiane (36,2%) è costituito da una sola persona. Le coppie con figli rappresentano meno del 30%, mentre aumentano le famiglie monogenitoriali (10,8%) e quelle senza figli (20,2%).
Italia che invecchia: 1 su 4 ha più di 65 anni
L’età media della popolazione ha raggiunto i 46,8 anni. I residenti over 65 sono 14,6 milioni (24,7% della popolazione), in crescita. Particolarmente significativa la crescita degli ultra85enni (2,4 milioni) e degli ultracentenari (oltre 23.500, l’83% donne). Solo l’11,9% della popolazione ha meno di 14 anni.
Il 2024 si conferma un anno di svolta per la demografia italiana. I segnali di allarme sono molteplici: una natalità ai minimi, una popolazione sempre più anziana, un tessuto familiare che cambia e una mobilità che accentua le disuguaglianze territoriali. Politiche strutturali, investimenti nei servizi per le famiglie, nel lavoro giovanile e nell’integrazione potrebbero essere le leve per invertire una rotta che appare oggi sempre più in discesa.