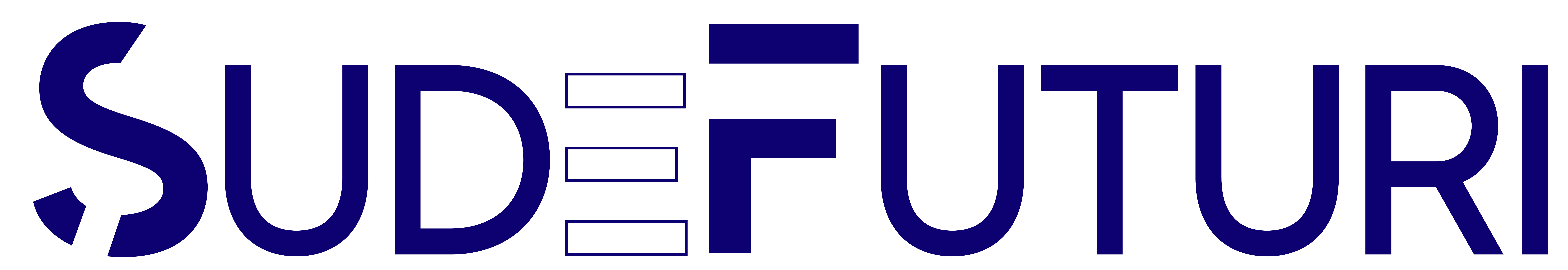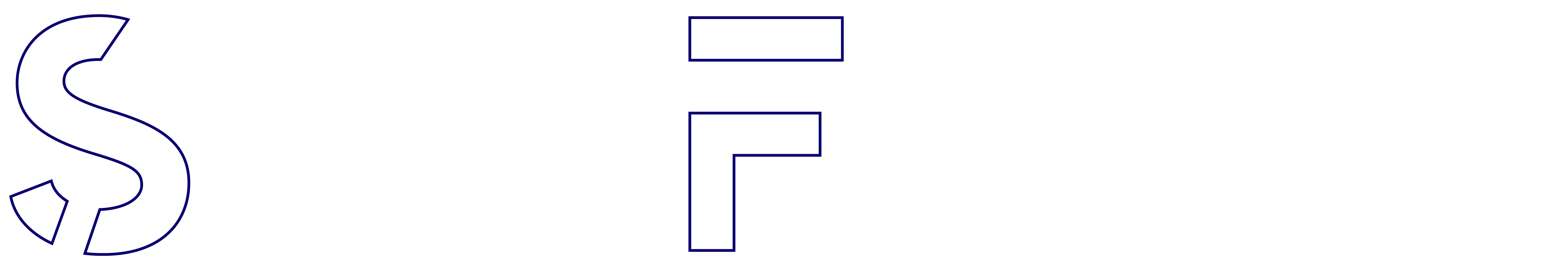Chissà se qualcuno recitò per lui il kaddish, la preghiera ebraica che accompagna i morti da questa vita all’altra. Chissà se qualcuno, davanti alle sue spoglie, si augurò che ”scenda dal cielo un’abbondante pace ed una vita felice su di noi e su tutto il popolo d’Israele. Colui che fa regnare la pace nell’alto dei cieli, nella sua infinita misericordia la accordi anche a noi e a tutto il popolo d’Israele”. Forse è accaduto, anche se è difficile che le parole della lode a Dio del popolo ebraico siano risuonate tra le mura dell’ospedale psichiatrico di Girifalco quando, era il 30 settembre del 1943, la gente, travolta dalla guerra, aveva forse altre cose da pensare che dare a Moshe l’ultimo conforto prima del grande viaggio. La storia di Moshe, della famiglia israelita degli Hanan, originaria dell’isola greca di Rodi, dove dalla notte dei tempi c’era una radicata comunità israelitica, è forse simile a quella di molti altri ebrei che vissero – e morirono – la grande tragedia dell’olocausto. Ma Moshe, a differenza della moglie, deportata nel campo di sterminio nazista di Birkenau, dove morì in una camera a gas, sfuggi a quel destino tragico. Lui, ebreo osservante, quando la sinagoga del suo villaggio fu chiusa, iniziò a percorrere i tortuosi meandri di una mente oppressa dalla depressione, che all’epoca non era ancora definita clinicamente come oggi e che veniva curata semplicemente imprimendo, sul resto della vita di chi ne era colpito, il timbro della pazzia irreversibile.
La depressione, passaporto verso la follia
Moshe non era pazzo, solo che le domande che si poneva ogni giorno, e che forse riguardavano il suo rapporto con Dio incrinato dalla mancata mediazione della sinagoga, restavano senza risposta, semplicemente inascoltate. Le giornate passate in solitudine e nel mutismo, nonostante fosse circondato dalla famiglia (la moglie e una nidiata di figli), spinsero chi lo amava a pensare di aiutarlo spedendolo in un manicomio. Rodi, a quel tempo, era parte dell’Impero italiano e, pur con tutti i distinguo del caso, ebbe governanti che molto si spesero per restaurare il patrimonio storico ed artistico dell’Isola e per darle una rete di infrastrutture degne di tale nome. Rodi italiana, quindi, e di conseguenza le autorità acconsentirono a che il ”malato” Moshe fosse mandato in Italia per essere curato (o, forse, per essere più vicini alla verità, per alleviare alla famiglia il peso della sua gestione quotidiana). Destinazione finale fu l’ospedale psichiatrico di Girifalco, il più grande da Napoli in giù. Lui, Moshe, ci arrivò cinquantasettenne, nel 1940, quando ancora qualcuno sperava che la guerra sarebbe stata vinta.
Uscirai guarito
Non sappiamo se Moshe conoscesse l’italiano (è forse probabile, visto lo status dell’Isola dai primi anni Dieci del secolo scorso). Difficilmente comunque, lui che era un falegname, conosceva il latino e quindi è arduo pensare che capì il senso della targa che, scritta in latino, campeggiava sull’ingresso principale del nosocomio, ”Sanus egredieris”, ”Uscirai sano”, che simboleggiava come anche lì, nel cuore della Calabria catanzarese, la sola missione dei medici era guarire i pazienti. Moshe, che non si riprese mai dalla depressione, morì tre anni dopo. Lo hanno scoperto due suoi pronipoti, Edoardo e Giuseppe che a Girifalco – uno proveniente da Roma, l’altro da Tel Aviv – hanno raccolto certezze sulla sorte del loro avo, di cui avevano sentito tanto parlare, ma di cui non conoscevano la sorte se non che fosse morto ”da pazzo”. I due giovani sono riusciti a trovare, nell’archivio dell’ospedale, la cartella clinica di Moshe scoprendo che egli morì alla fine dell’estate del ’43, all’oscuro del fatto che la sua famiglia si stava sfaldando sotto i colpi della follia nazista. Ma i figli di Moshe sopravvissero ai genitori e una di loro è la nonna dei due ragazzi arrivati a Girifalco in cerca delle loro radici. Un viaggio all’incontrario per due ragazzi che hanno tutta la vita davanti, ma che hanno pensato che la loro sarebbe stata un’esistenza imperfetta se non avessero trovato, con la memoria storica del bisnonno, anche le ragioni del loro vivere il presente, figlio della disintegrazione di una famiglia che la spaventosa tragedia della seconda guerra mondiale ha colpito duramente. Edoardo e Giuseppe, affatto spaventati dalle difficoltà pratiche della loro missione, hanno saputo quale fosse stata la fine del loro avo, ma non hanno trovato una tomba che portasse il suo nome.
Le parole del kaddis davanti a una tomba che non c’è
Per non hanno potuto fare altro che rivolgere a Dio una preghiera per raccomandargli Moshe e la sua anima, con le parole del Kaddish: ”Egli sia, al di sopra dio ogni benedizione, canto, celebrazione e consolazione che noi pronunciamo in questo mondo”. Lo hanno fatto davanti a quella porzione del cimitero di Girifalco che conserva, spesso indistinte, le spoglie di chi dello psichiatrico fu per lungo tempo paziente e che – come spesso accadeva -, dimenticato dalla famiglia, era quasi adottato da quella eterogenea e comunitaria, composta da altri pazienti, dai medici ed infermieri, dalla gente del paese. L’ospedale, ospitato in un vecchio convento di frati minori, dedicato ai santi Antonio ed Elena, ha avuto una singolare storia diventando, piuttosto che un luogo di anomala detenzione per coloro che la società non accettava più etichettandoli come matti, un enorme crogiuolo di iniziative talmente all’avanguardia da apparire rivoluzionarie. Perché ci voleva un pizzico di incoscienza, ben prima di Franco Basaglia, a lasciare i pazienti liberi di uscire dall’ospedale per andare lungo le strade del paese. Liberi di camminare, ma anche di intessere rapporti e forse pure amicizie che non si concretizzavano solo nel regalare loro qualche sigaretta. Gesti di normale convivenza che la gente di Girifalco considerava una mano tesa per quelli che l’altra società, quella ufficiale, rifiutava. Forse Moshe era tra quelli che chiedevano ad un passante una sigaretta, un tozzo di pane o un frutto. Forse a Moshe, come a molti altri accadeva, veniva offerto un bicchiere di latte o di vino da chi sapeva che quel gesto, in un mondo egoistico, sarebbe finito lì, senza alcuna ricompensa.
Girifalco, l’ospedale psichiatrico che spezzò le sbarre
Girifalco, come il suo ospedale psichiatrico dalle porte aperte, più che un luogo fisico è stato per Moshe Hanan un viatico per lenire i morsi con i quali la malattia consumava la sua mente e la sua voglia di vivere. Ma nel settembre del 1943 la sua vita si consumò, ignorando che i suoi fratelli ed amici di Rodi stavano per essere spazzati dalla Terra dai rastrellamenti, dalla cattura, dalle navi e dai treni che li avrebbero portati nel ventre della bestia nazista, quasi tutti finiti a inghiottire Zyklon B nelle camere a gas di Auschwitz, come i nazisti, con arroganza, avevano ribattezzato la cittadina polacca di Oświęcim. Per tanto tempo gli abitanti di Girifalco sono stati, per i pazienti, degli amici, tanto che spesso li invitavano a pranzare e, nell’occasione, mettevano sulla tavola molto più cibo del solito per saziare la fame dei loro ospiti. Una consuetudine che è anche diventato per Girifalco un modo di dire quando si vuole sottolineare, con il sorriso, che si è esagerato nelle quantità in cucina: ”Cucinasti pe’ i pacci?”, hai cucinato per i pazzi?, perché quei pasti erano spesso preparati, con porzioni enormi, solo per fare sfuggire ai pazienti la routine della mensa dell’ospedale. Davanti ad un ossario che non restituirà mai i resti del loro avo, i due ragazzi venuta da Roma e Tel Aviv hanno coltivato una speranza: che anche il funerale di Moshe, oltre a quella di medici ed infermieri, abbia avuto la partecipazione di molti abitanti di Girifalco, per quella che non era una consuetudine, ma il senso di una comunità che non guardava a sbarre, etichette, rituali, ma solo all’uomo.