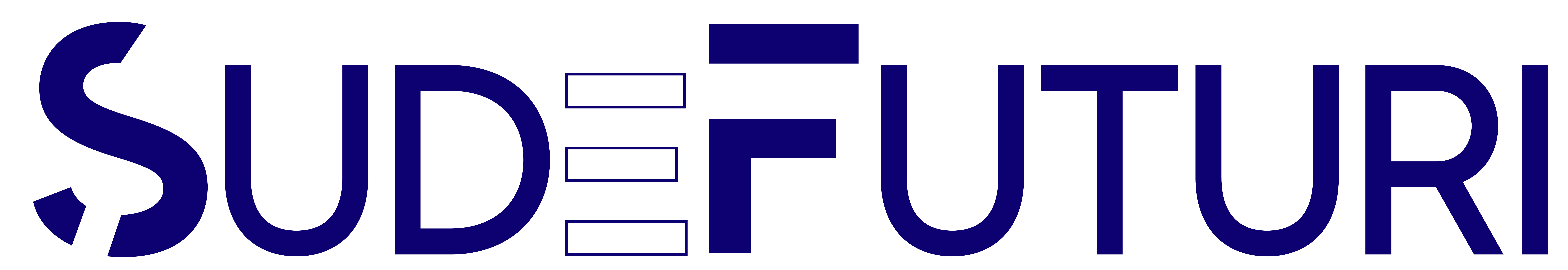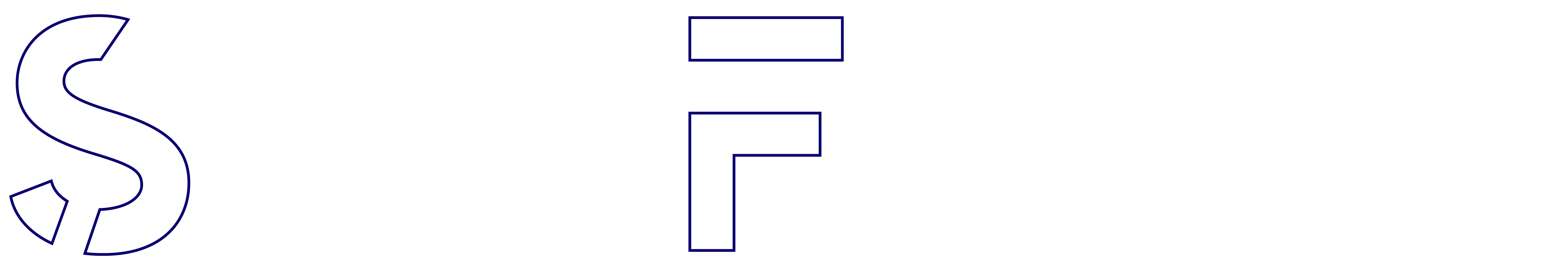Dalla pandemia a una nuova epidemia: l’obesità è una malattia, non una scelta. E come tale va compresa e affrontata: non mancano le diete, ma l’educazione
Una delle prime diete fai da te della storia la inventò Guglielmo il Conquistatore, che, dopo la Battaglia di Hastings, bevve solo alcol per dimagrire. Riuscì a perdere peso ma poi ingrassò di nuovo, tanto che alla sua morte dovettero dimezzarlo per metterlo nella bara. La ragione per cui tentò di dimagrire fu pratica: non riusciva più a montare a cavallo.
Oggi, invece, sappiamo tutti due cose relative all’obesità. Che è un fenomeno in crescita in grossa parte dell’Occidente, tanto da parlare di epidemia; e che è stato definito una malattia. Per la precisione questa definizione nasce nel 2013 con una decisione dell’American Medical Association, seguita a ruota da altre associazioni governative americane. La scelta non fu unanime. Si dichiarò contraria all’iniziativa l’intera Commissione di Scienza e Salute della stessa associazione, perché mancavano criteri scientifici per definire l’obesità malattia, ed era limitante usare l’indice di massa corporea. Tuttavia, ora che l’obeso è considerato un malato, è anche l’unico ritenuto responsabile dall’opinione pubblica della sua malattia. E in quanto responsabile, stigmatizzato.
Per capire la gravità di questo unicum bioetico, immaginate di incontrare una persona affetta da qualsiasi altra malattia, e decidere dopo averla salutata di prenderla in giro per la sua patologia. Nessuno farebbe una cosa del genere, no? Sarebbe come minimo considerata mancanza di empatia. O un segno di stupidità. La stessa che hanno dimostrato i conoscenti della dottoressa Harriet Brown, scrittrice e giornalista, quando si sono complimentati con sua figlia adolescente Liz per la sua forma fisica. Peccato che la ragazzina fosse anoressica.
RUNNER IS THE NEW FAT
Andando a vedere le cause dell’obesità, a parte l’eccesso calorico e la mancanza di esercizio fisico, sono tantissimi gli studi che si sono concentrati su altri fattori determinanti. Ambientale, genetico, ormonale, immunitario, di set point e via dicendo. Tanto che, al momento, la Obesity Medicine Research definisce l’obesità come malattia cronica e recidivante di tipo multifattoriale e neurocomportamentale.
Se anche riducessimo l’obesità a eccesso alimentare e sedentarietà, dovremmo chiederci perché intanto l’industria delle diete fattura miliardi, così come quella del wellness, eppure non si è trovata la soluzione a questa epidemia. Sono poi numerosi gli studi che “limitano” gli effetti dell’esercizio fisico al miglioramento dei parametri di salute, ma non al dimagrimento tout court. Esistono infatti atleti obesi.
Tempo fa, la dottoressa Traci Mann condusse una review sull’effetto delle diete. Analizzò 31 studi che avevano coinvolto centinaia di migliaia di individui, scoprendo che l’83% delle persone a più di due anni dalla fine della dieta pesava più che al suo inizio. L’essere stati a dieta dimagrante è predittivo di un nuovo accumulo di peso.
Considerando che una donna fa in media 130 diete nel corso della sua vita, è plausibile credere che le persone grasse siano state a dieta come tutte le altre. Se la dieta non basta, perché stigmatizziamo chi è grasso? Perché gli diamo lezioni di vita?
il fat shaming
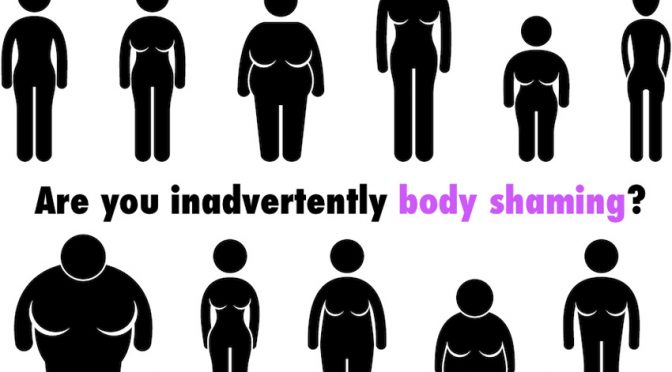
Probabilmente le ragioni sono le stesse che hanno portato molti, durante la pandemia Covid-19, a lamentarsi dei loro concittadini che uscivano per andare a correre. Quando le istituzioni non danno risposte adeguate alla risoluzione di un problema, il singolo si fa carico di quest’onere, ma in chiave più moralista. I primi “runner da additare” sono stati gli obesi e chi è in sovrappeso. Basta mostrarsi in foto con qualche chilo in più per fare scattare l’allarme mediatico e social. L’obeso è senza dubbio un pigro e un mangione. Il sovrappeso diventerà obeso, dunque è bene redarguirlo.
Questo meccanismo si chiama fat-shaming (bullizzare il grasso, potrei definirlo) e fa parte di quel body-shaming che è un fenomeno di cui sono vittime coloro che non rientrano in una taglia o in un’estetica standard. Si fa body-shaming sui grassi, sui magri, su chi ha una menomazione fisica. Il moralizzatore parla di rischi per la salute, di aggravio per la spesa sanitaria pubblica, di cattiva educazione sulle giovani menti, di fastidio, di danni all’immagine, per cui il bullizzato non deve solo vergognarsi del suo aspetto, ma è anche un parassita. Dovremo dire le bullizzate, in realtà, perché le prime vittime di body-shaming sono le donne.
Abbiamo tutti, più o meno, un’idea dei rischi per la salute che corre chi è obeso. Ma quanto ne sappiamo esattamente noi dell’obesità?
OBESITÀ: QUANDO I CONTI NON TORNANO

Innanzitutto partiamo dal range di indice di massa corporea che definisce una persona sottopeso, nella norma, sovrappeso o obesa. Il primo problema si riscontra qui. Non esiste una catalogazione univoca, ma ce ne sono state diverse. Consideriamo solo quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sotto 18.5 (kg/m2) si è sottopeso. Da 18.5 a 24.9 si ha un peso nella norma. Da 25 a 29.9 si è in pre-obesità, e già qui abbiamo qualche problema.
Non c’è il criterio di sovrappeso ma di pre-obeso, mentre gli studi parlano più propriamente di sovrappeso. Dal 30 al 34.9 abbiamo obesità di primo grado, poi a seguire di secondo e di terzo grado.
Questa classificazione è cambiata nel corso degli anni, a partire dal 1990.
Il fatto che non ci siano state classificazioni di indice di massa corporea univoche porta tuttavia a un problema di uniformità delle statistiche. Chi era sovrappeso o pre-obeso secondo una classificazione è poi diventato obeso nelle successive. Quindi a un certo punto ci siamo trovati con molti più obesi rispetto a prima anche per un discorso di definizioni. Sempre l’OMS ignora la definizione di obesità secondo la Obesity Medicine Research e altre organizzazioni mondiali, limitandosi a dire che le cause sono l’eccesso alimentare e la mancanza di movimento.
E così snobba la mole di studi e ricerche sulle altre cause dell’obesità.
Andando a vedere i rischi di salute, non troviamo associazioni significative con maggiore rischio di mortalità nelle fasce di normalità del peso, di sovrappeso e persino di grado uno di obesità. In aggiunta, l’aspettativa di vita è la stessa tra chi è sottopeso e chi è obeso di primo grado, con BMI maggiore di 30 ma inferiore a 34.9: si parla della stessa riduzione dell’aspettativa di vita, di circa 4 anni. Questo significa che una persona sovrappeso o con BMI inferiore a 30 vive in media più a lungo di una sottopeso. Tuttavia non si salva dall’essere discriminata.
Tra le cause di rischio di mortalità associate al sovrappeso, abbiamo fattori di comorbidità come rischi cardiovascolari, polmonari, epatici, nonché di depressione, diabete, sindrome metabolica, problemi osteo-articolari, neoplasie.
DISCRIMINAZIONE + PERCEZIONE COLLETTIVA = DANNO
Ma esiste un rischio di mortalità nelle persone che sono vittima di stigmatizzazione del peso? Sì.
Ecco cosa rischia chi è vittima di body e fat-shaming secondo la letteratura scientifica: depressione, malattie cardiovascolari, dipendenza da alcol, farmaci o droga, obesità e sue conseguenze, disordini alimentari. Il rischio che maggiormente colpisce è proprio quello dell’obesità, per cui il bullizzato tenderà semmai ad avere un peggioramento della qualità della vita e non a migliorarla. Ad aggravare la cosa ci sono gli studi che parlano di comportamenti di fat e body-shaming da parte del personale medico, che passa meno tempo ad ascoltare una persona obesa o sovrappeso, ritenendola colpevole dei suoi problemi e prestandogli di conseguenza meno attenzione.

Come se non bastasse, le iniziative finora intraprese per contrastare il fenomeno subiscono critiche severe e forme di semplificazione mediatica. In molti vedono i movimenti di Body Positivity come sottoprodotto del femminismo, quasi fosse un insulto; o peggio, come una scusa per le persone obese di rimanere tali. Due cose false che, finora, hanno procurato una degenerazione della percezione collettiva, per cui, come afferma Virgie Tovar, attivista e scrittrice, alle persone obese si chiede solo una cosa: di sparire. E significa ignorare iniziative importanti come la HAES, ovvero la promozione della Salute a ogni Taglia, dove i medici lavorano in sinergia perché le persone di qualsiasi taglia abbiano uguali opportunità di ascolto, tutela e cura attraverso approcci non dietetici.
NON SONO LE DIETE A MANCARE, MA L’EDUCAZIONE
Quello che manca non sono infatti le indicazioni dietetiche, ma tutti quei progetti indirizzati a migliorare la qualità della vita di chi ha una taglia non standard, educando al contempo l’opinione pubblica. Per esempio l’attività fisica come finalizzata non a perdere peso, ma al divertimento, all’incremento delle capacità motorie o alla riduzione dello stress. Percorsi alimentari che non sono prescrittivi, ma orientati al prendersi cura di sé stessi: come corsi di cucina, fitoterapia e altri. Mai parlare di dieta giusta o sbagliata, di cose da fare o non fare. Mai colpevolizzare.
Corsi di consapevolezza mentale o mindfulness e altri di sostegno terapeutico. Corsi dedicati al personale medico e paramedico. Corsi scolastici. Corsi che parlano di intimità e desiderio di relazione.
Creare progetti simili in Italia potrebbe tradursi in una maggiore presa di consapevolezza da parte di tutti, in una riduzione della spesa sanitaria, in misure di intervento più umane che rimettono la persona al centro della sua vita. Ed è importante che sia il Sud a fare il primo passo, proponendo approcci alternativi in linea con i valori della convivialità, della condivisione, nell’ottica non più di una dieta mediterranea, ma di una vita mediterranea.